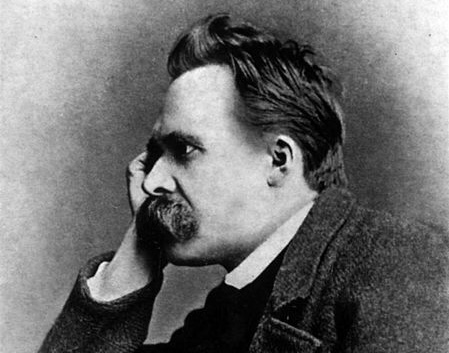Eterna Amistad. Una eterna amicizia, un racconto di quelli che, forse più di altri, attribuiscono un senso alla memorabile affermazione di Gianni Brera: “Il calcio è straordinario proprio perché non è mai fatto di sole pedate. Chi ne delira va compreso, non compatito; e va magari invidiato”. Il legame fra la squadra argentina del River Plate e quella italiana del Torino, non ha eguali nel mondo del calcio e, più in generale, dello sport. Il racconto di questo episodio, che appartiene alla Storia, quella con la S maiuscola, è dedicato ad Antonio V. Liberti – uomo poliedrico, argentino e genovese, il presidente che per primo ha reso grande il River – e a Ferruccio Novo, ingegnere ed industriale piemontese, presidente ed architetto del Grande Torino. Il rapporto di amicizia fra il sodalizio albirrojo [biancorosso] e quello granata, maturato dopo la tragedia di Superga, è cosi intenso e attuale da giustificare la celebrazione dedicata dallo sponsor tecnico del River Plate, che ha deciso di valorizzare il cosiddetto “rito granata”, attraverso una splendida camiseta con historia realizzata per accompagnare il River durante le trasferte nel campionato argentino e in Coppa Libertadores, nel nome di un hashtag rivolto al pubblico di tutto il mondo: #EternaAmicizia!
Ho scoperto questa magnifica storia mentre mi trovavo a Mendoza, il capoluogo di una vasta regione dell’Argentina, addirittura la quinta fra le aree vinicole più importanti al mondo. Avevo scelto quella città come base ideale per il mio progetto di esplorare le bodegas [cantine] che si trovano nel suo circondario e a quello scopo ero partito da Buenos Aires con un volo interno della compagnia di bandiera. Luoghi incantevoli, ai piedi delle Ande, dove cresce la materia prima che poi l’uomo trasforma nei migliori interpreti della personalità argentina: il Malbec, un vino rosso intenso dalla struttura possente e quasi impenetrabile, e il Torrentés, un vino bianco aromatico e morbido, ma esplosivo, autentici campioni dell’enologia nazionale. Tuttavia, passeggiando per il centro cittadino di Mendoza, fui attratto dalla vetrina di un negozio di articoli sportivi dove accanto alla maglietta della squadra di calcio locale – il Godoy Cruz – e alle immancabili divise del Boca Juniors e del River Plate di Buenos Aires, avevo riconosciuto un gagliardetto sociale e la maglia del Torino. Non dell’Inter, della Juventus o del Milan, ma del Toro. Non seppi resistere alla curiosità, e decisi di entrare per domandare il motivo di quella preferenza. Mi fu svelato quindi il legame del Toro con il Sudamerica: che nacque in ragione di ben tre storiche tournée estive, avvenute nel 1914, 1929 e 1948, e venne poi esaltato dal River Plate quando decise di onorare i caduti a Superga del Grande Torino, giocando nel 1949 allo stadio Comunale del capoluogo piemontese contro il cosiddetto Torino Simbolo, e ancora a Buenos Aires nel 1951 e quindi di nuovo a Torino nel 1952: quello fu il principio di questa storia di #EternaAmistad [Eterna Amicizia].

Ma andiamo con ordine, e quindi dal principio. Vittorio Pozzo non ha bisogno di presentazioni, tuttavia non tutti sanno che, prima di diventare il più vincente tecnico di sempre, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1934 e nel 1938 e campione olimpionico nel 1936, fu uno dei primi allenatori del Torino, squadra che aveva contribuito a fondare, si dice. Comunque, fra le tante intuizioni non scontate Pozzo ne ebbe una, che oggi può persino sembrare ovvia: se il Torino voleva crescere e migliorare doveva giocare tanto e non solo in Italia, misurandosi con avversari di caratura e tradizioni differenti, allo scopo di imparare da ognuno di loro. Fu così che, convinta la dirigenza, Pozzo ottenne per la prima volta nella storia del Toro, il permesso di disputare in quella estate del 1914 una tournée oltreoceano: la squadra si imbarcò da Genova, attraversando l’Atlantico sul piroscafo Duca degli Abruzzi e arrivò dopo quasi un mese di navigazione, e tanti palloni finiti in mare, al porto della città di Santos in Brasile, dove le squadre locali erano desiderose di confrontarsi con un’avversaria italiana di primo piano, capace di contendere in quella stagione al leggendario Genoa il titolo di campione d’Italia; i brasiliani li avrebbero quindi ospitati volentieri per circa un mese ai granata e diviso con loro gli incassi delle partite. La comitiva del Toro in quella estate lasciò il segno: São Paulo era una grande città, una metropoli, e gli italiani furono sommersi da inviti e occasioni mondane, come accadde alla Pro Vercelli, altra squadra piemontese che stava visitando il Sudamerica, che invece si distinse in negativo, sia per la condotta in campo e fuori; invece quanto ai granata l’inflessibile Pozzo ridusse al minimo ogni distrazione e tutte le tentazioni, imponendo come suo costume regole di condotta ferree, improntate alla disciplina e alla massima sobrietà, e i risultati furono evidenti anche in campo. Il Torino, con un vigore insospettabile, liquidò all’esordio, il 9 agosto 1914, lo Sport Club International (0-6), per ben due volte la rappresentativa del São Paulo (1-5; 1-7) e lo Sport Club Luzitano (0-3), vincendo due volte anche contro i campioni nazionali dello Sport Club Corinthians (0-3; 1-2) destando così grande ammirazione anche nella vicina Argentina, dove il calcio era già una malattia, e ricevendo un invito fuori programma: quello di raggiungere Buenos Aires. Nella capitale argentina il Torino – tanto era stimato – affrontò la Nazionale bianco-celeste, che lo sconfisse di misura (2-1), perse poi contro il Racing Club de Avellaneda (1-0), che era l’imbattuto campione d’Argentina, congedandosi però con una vittoria netta contro una selezione dei migliori giocatori della Liga argentina (0-2): era il 6 settembre 1914. Poco dopo il rientro in patria della comitiva granata, anche l’Italia sarebbe stata travolta dalla prima guerra mondiale.

Il Torino di Pozzo sfiorò in diverse occasioni il successo nel campionato italiano, ma non lo vinse; mentre la formazione granata del cosiddetto “Trio delle Meraviglie”, composto dai campionissimi Libonatti, Baloncieri e Rossetti, viaggiò in Sudamerica nella tournée del 1929 avendo vinto l’anno prima lo scudetto della stagione 1927/28, bissando il titolo (ingiustamente) revocato nel 1926/27; a dispetto del palmares tuttavia quel Torino non brillò, anche se fu apprezzato dai tantissimi immigrati italiani (e piemontesi) che andarono ad applaudirlo. I granata iniziarono a Buenos Aires il 28 luglio 1929 e giocarono in quella prima settimana ben tre partite contro la Nazionale argentina, perdendone due (1-0; 4-1) e infine riuscendo a pareggiare (1-1), in seguito furono sconfitti severamente dall’Estudiantes de la Plata (5-0) ma espugnarono il fortino dell’Independiente de Avellaneda (1-2); quindi si trasferirono nella città di Rosario dove sconfissero il Central (2-4) e persero nettamente di fronte all’altra squadra di casa, il Newell’s Old Boys (2-0). A quel punto la comitiva granata raggiungerà Montevideo, dove subirà una sconfitta netta contro la Nazionale uruguagia (5-1) ma riuscirà a pareggiare coi campioni d’Uruguay, i giallo-neri del Club Atlético Peñarol (1-1), prima di mettersi in viaggio per il Brasile. Questa volta il Torino – sicuramente affaticato dalle centinaia di chilometri macinati in treno – sarà duramente sconfitto al São Januário (6-0; 2-1), all’epoca lo stadio più grande del paese, dalla “combinata” carioca di Rio de Janeiro (composta dai giocatori di América, Botafogo, Fluminense e, sopratutto, Vasco de Gama), e dopo aver pareggiato (0-0) con il Paléstra Italia, che poi diventerà il Palmeiras, il Toro sarà travolto (6-1) da una “combinata” paulista, composta essenzialmente dai giocatori dello Sport Club Corinthians di São Paulo, chiudendo così quel lungo ed estenuante viaggio il 14 settembre 1929.

Anche il Grande Torino visiterà il Sudamerica. Nell’estate del 1948, anticipato dall’etichetta di squadra più forte del mondo e quindi generando aspettative e curiosità. La società granata, costruita dal presidente Ferruccio Novo, stava in effetti dominando il calcio italiano dal 1943 (e da allora non perdeva una partita in casa, al mitico campo del Filadelfia) e il 4 luglio aveva trionfato nel campionato italiano ancora una volta, annichilendo ogni avversario: in quel torneo il Grande Torino aveva schierato appena 15 giocatori, nell’arco di una lunga stagione a 21 squadre, confermandosi la migliore difesa (33 gol subiti) e il migliore attacco (125 gol realizzati), con il capitano Valentino Mazzola, oramai leggendario condottiero del cosiddetto “quarto d’ora granata” – quando si arrotolava le maniche e il Toro travolgeva chiunque – capace di segnare 25 gol. I granata, che si erano fatti apprezzare anche in Europa vincendo diverse amichevoli di prestigio, dal Belgio alla Spagna, conquistarono quello scudetto con diverse giornate di anticipo e con ben 16 punti di vantaggio sulle seconde classificate: il Milan, la Juventus e la Triestina. Quindi, dopo essersi imbarcati su un volo di linea della compagnia aerea brasiliana, i giocatori granata raggiunsero São Paulo dove rimasero dal 18 al 28 luglio, giocando in quei pochi giorni, ben quattro amichevoli: persero contro lo Sport Club Corinthians (2-1), pareggiarono con il Palmeiras (1-1) e il São Paulo (2-2), e vinsero poi contro la Portoguesa (4-1), entusiasmando il pubblico brasiliano e approfittando per prendere confidenza con l’ambiente del paese che avrebbe ospitato i campionati mondiali di calcio nel 1950, dove la Nazionale italiana avrebbe difeso il titolo conquistato nel 1934 e bissato nel 1938; Nazionale azzurra che – è bene ricordarlo – solo l’anno prima aveva sconfitto l’Ungheria, schierando dieci giocatori del Grande Torino su undici, in campo.

Nello stesso decennio però anche un squadra argentina era accreditata da molti critici e osservatori come la più forte al mondo: il River Plate, la grande squadra di Buenos Aires, che in quella decade segnò una vera e propria epoca. Negli anni Quaranta del secolo scorso infatti la Primera División era contesa principalmente da tre squadre, tutte molto forti: il Boca Juniors, campione nel 1943 e nel 1944 e il San Lorenzo de Almagro, campione nel 1946; ma nessuna si affermerà come il River che sarà campione nel 1941, 1942, 1945 e 1947 mancando per un soffio la vittoria, arrivando secondo, nel 1943, 1944, 1948 e 1949. Quella squadra impressionò, grazie a uno stile di gioco mai visto a quelle latitudini in precedenza: l’occupazione tattica degli spazi si sommava alla velocità di esecuzione e alla precisione delle giocate dei suoi cinque formidabili attaccanti: Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Amedeo Labruna e Félix Loustau e Adolfo Pedernera, soprannominato El Maestro è il giocatore che ha inventato in Sudamerica il ruolo di trequartista, e che favorì l’inserimento – nell’ingranaggio, è proprio il caso di usare questo termine – di un altro mostro sacro Alfredo Di Stéfano. Infatti, ci si riferisce abitualmente a quel River Plate definendolo “La Máquina”, che potrebbe apparire un soprannome poco evocativo e quindi va contestualizzato: fu Ricardo Rodríguez, uno dei più grandi giornalisti sportivi sudamericani a coniarlo, quando nel 1942 dopo una partita contro il Chacarita Juniors, annientato per 6-2 al Monumental, scrisse a proposito del River su “El Gráfico” un articolo titolato “Jugó como una máquina”, dove esaltava il collettivo biancorosso: “El tiempo, el buen entrenamiento, la moral que posee el equipo y el valor individual de sus componentes, todo ha contribuido para que River en los actuales momentos dé la sensación de ser una máquina”. Dopo di lui, Eduardo Galeano, una delle personalità più autorevoli della letteratura latinoamericana e grande appassionato nonché fine conoscitore di calcio, proiettò quel River nella giusta dimensione paragonando quel gioco al totaalvoetbal di Rinus Michels, che alla guida dell’Olanda e dell’Ajax di Amsterdam rivelò al mondo il “calcio totale”, che La Máquina in realtà giocava trenta anni prima.

Un uomo in particolare segnò la storia del River Plate, assemblando “La Máquina”, esattamente come Furruccio Novo, che in quegli anni costruiva il Grande Torino: il presidente don Antonio Vespucio Liberti; fin da ragazzo trascorreva tutto il suo tempo aiutando i magazzinieri al campo di allenamento del River, dove lo chiamavano El Gordo, a causa della costituzione pingue, già in tenera età, ma tutti gli volevano un gran bene, considerandolo una sorta di mascotte. Una volta cresciuto, raggiunto il successo negli affari e addirittura la ricchezza, don Antonio venne eletto a furor di popolo – di soci, pardon – alla presidenza del club, governandolo a più riprese in un arco temporale di oltre due decadi, riuscendo a realizzare il suo sogno: rendere grande il River, ma grande davvero, senza badare a spese e attingendo largamente alle proprie finanze personali. Appena arrivato alla presidenza del sodalizio, che da circa un ventennio non vinceva, in un clima generale di rassegnazione dei propri tifosi, don Antonio decise di scuotere l’ambiente: fece confezionare, rinnovandole, le mitiche maglie bianche con la banda rossa in diagonale, provvedendo a consegnarle personalmente ai suoi giocatori, che ammoniva, uno per uno: “Cuídenla mucho, porque ésta es la camiseta de River”, come dire, cerca di averne cura e di meritarla, perché questa è la maglia del River!, in seguito decise di mettere mano al portafoglio per acquistare due giocatori straordinari: Carlos Peucelle, dal Club Sportivo, e Bernabé Ferreyra, dal Club Tigre, per una somma a quei tempi inaudita, pagata per la maggior parte in lingotti d’oro, meritando così il soprannome che da allora accompagnerà il club della capitale: “Los Millonarios”.

Don Antonio però aveva appena iniziato. E con l’entusiasmo che cresceva in modo irrefrenabile intorno al club decise di comprare un vasto terreno ai margini del prestigioso quartiere di Núñez e nel 1935 diede inizio alla costruzione di uno stadio gigantesco, inaugurato non appena furono agibili tre delle quattro tribune previste: nel 1938 era pronto. Il Monumental si presentava con il suggestivo aspetto di un ferro di cavallo, aperto verso il Río de la Plata, già in grado di ospitare ben oltre 60 mila spettatori; alla fine degli anni Cinquanta verrà attuata poi la chiusura dell’ovale, con la costruzione del primo anello della quarta tribuna, finanziata con il denaro pagato dalla Juventus al River, a seguito della cessione di Omar Sívori ai bianconeri. Don Antonio decise di affidare la sua squadra che iniziava a prendere forma a un giovane tecnico ungherese: Imre Hirschl, che aveva trasferito in Sudamerica il proprio know-how mitteleuropeo; don Antonio fu coraggioso, ma il giovane tecnico lo ripagò: grande equilibrio difensivo e rapidi cambiamenti in campo nella disposizione dei ruoli, a seconda delle fasi di gioco, portarono il River Plate alla vittoria del campionato nel 1936 e nel 1937 gettando le basi di quel gruppo formidabile che il suo successore affinerà. Toccherà infatti a Renato Cesarini, la celebre ex mezzala sinistra della nazionale italiana e della Juventus, di trasformare quella squadra già molto forte ne “La Máquina”, ovvero la rappresentazione dominante, anche sul campo da gioco, di quello che era diventato il River Plate: un club ambizioso e solido finanziariamente, ottimamente organizzato e gestito secondo criteri imprenditoriali, con uno stile che Liberti amava definire fútbol empresa e che Cesarini, insieme a Carlos Peucelle, nel frattempo ritiratosi dall’attività agonistica e diventato il direttore tecnico del club, riuscirà a trasferire nella prestigiosa “Escuela de River”. Lì nasceranno talenti del calibro di Alfredo Di Stéfano e Omar Sivori, per citare solo i due più celebri.

In quel periodo così denso di successi Don Antonio amava ripetere: “Dios no me dio la posibilidad de tener hijos pero me dio otra chance: ese lugar para mí lo ocupa River!” Non aveva mai avuto i figli che tanto avrebbe desiderato, ma Dio gli aveva concesso il privilegio di colmare quel vuoto occupandosi del River Plate!, che peraltro era di grande supporto alla Nazionale argentina, capace in quella decade di vincere quattro volte su cinque il massimo trofeo continentale, la Coppa América. Intanto, sulla sponda europea dell’Atlantico, un altro uomo aveva attraversato quel decennio dedicando tutta le sue energie alla squadra di calcio del suo cuore: il Torino; anche lui con l’obiettivo di renderla grande. L’Ing. Ferruccio Novo però stava per vivere un dramma senza pari, che nessuno al mondo avrebbe mai più dimenticato: accadde il 4 maggio 1949, la tragedia di Superga. Quel giorno sul Piemonte ed in particolare su Torino era in corso una tempesta di vento, pioggia e lampi, mentre la nebbia avvolgeva le pendici delle colline lambendo la città; ad un certo momento del pomeriggio, pochi minuti dopo le cinque, si avvertì un boato terribile che rintronò nel grandioso edificio della Basilica. Il trimotore Fiat G.212 delle Avio Linee Italiane, con a bordo 31 persone, fra le quali l’intera squadra sportiva del Torino, di ritorno dall’estero, si schiantò a piena velocità contro il muraglione del terrapieno posteriore del grande tempio. Il cappellano, don Tancredi Ricca, accorse sul luogo dello schianto, dove erano nel frattempo convenuti alcuni volenterosi contadini per portare soccorso, ma purtroppo non c’erano sopravvissuti fra i rottami dell’aereo, solo sagome annerite dal fuoco. Uno spettacolo spaventoso. I bagagli della comitiva erano stati scaraventati lontano dalla carlinga, letteralmente esplosa e accartocciata contro il muraglione, e fu allora che fra i soccorritori si levò una voce: “C’è una maglia rossa … misericordia, sono quelli del Torino!” Al sacerdote, rientrato in Basilica, non restò che dare l’allarme per telefono: “Sono tutti morti!”

“Il Grande Torino è calcio, ma non soltanto”. Fu Dino Buzzati a scriverlo, quando il Corriere della Sera gli chiese, come inviato speciale, di seguire – e spiegare agli italiani – la tragedia; “Anche chi non sa di sport, anche chi non mai ha sentito nominare – ma è impossibile – Valentino Mazzola, e così anche l’intellettuale che non ha mai letto di sport e disdegna il calcio, oggi si sono sentiti stringere il cuore”, così scriveva Buzzati, perché “Il dolore è davvero di tutti. Il tifo non conta”. Secondo Gianni Brera la spiegazione di tanto affetto diffuso era che “Quei calciatori, considerati pressoché imbattibili da oltre quattro anni, ossatura della Nazionale, non sono per una città, non sono solo per una sua parte: perché il Torino era lo sport, era la sua sintesi più armoniosa. Il Torino era l’Italia”. Forse anche in ragione di questa speciale grandezza, la Federazione decise di proclamare ufficialmente il Torino vincitore del torneo e quindi conferirgli il titolo campione d’Italia 1948/49; anche se il sodalizio granata in realtà aveva totalizzato sino a quel momento 52 punti, e mancavano quattro turni alla fine del campionato (tre di quelli li avrebbe disputati in casa nell’inespugnabile Filadelfia); erano ben quattro i punti di vantaggio sulle inseguitrici dell’Inter e del Milan (ma il Torino non poteva contare più nemmeno un titolare da mandare in campo) è vero, ma furono proprio i dirigenti delle due squadre milanesi – che con 48 e 46 punti avrebbero potuto ancora aggiudicarsi lo scudetto – a proporre generosamente la proclamazione del Torino, approvata all’unanimità. Tuttavia alla ripresa del torneo, dopo Superga, il presidente Novo decise che il Torino sarebbe tornato in campo per disputare le ultime partite di campionato, allo scopo di onorare il gesto delle avversarie di proclamarlo campione d’Italia, schierando i migliori ragazzi delle giovanili, cosa che fecero cavallerescamente anche gli avversari del Genoa, della Sampdoria, del Palermo e della Fiorentina, vincendo così – il Torino – anche sul campo.

Quando la notizia della tragedia arrivò a Buenos Aires il presidente del River, don Antonio, si commosse profondamente: da tempo accarezzava l’idea di organizzare una sfida senza precedenti, il suo River Plate contro il Grande Torino, per incoronare la più forte squadra al mondo. Entrambe le compagini erano infatti senza rivali in patria e nessuno avrebbe osato mettere in discussione la loro superiorità, nemmeno a livello continentale. Purtroppo non sarebbe stato più possibile giocarla quella sfida. Allora Don Antonio decise: “Nos vamos a Turín”, perché il River aveva il dovere morale, secondo il suo presidente, di recarsi in Italia per rendere omaggio alla memoria di quei campioni appena caduti e alla squadra che era un mito sportivo e adesso era diventata immortale, offrendo inoltre l’occasione al sodalizio torinista di una concreta solidarietà verso le famiglie dei caduti, destinando loro l’incasso di una partita celebrativa da organizzare. Il presidente Novo giudicherà il gesto “Una immediata prova di fraterno amore, e di una grandiosità pari a quella della tragedia”. Fu così che il River, con tutti i suoi campioni e con l’approvazione del presidente argentino, il generale Juan Domingo Perón, e di sua moglie Evita, partì alla volta dell’Italia. Il 26 maggio 1949 ebbe quindi luogo a Torino una partita unica. Infatti, il Club Atlético River Plate, con indosso le casacche bianche attraversate dall’iconica banda trasversale rossa, scese in campo per affrontare un gruppo di undici fuoriclasse, prestati da tutte le squadre italiane, che per l’occasione indossavano la maglia granata e si chiamavano Torino Simbolo, in un Comunale al limite della capienza; la partita-spettacolo terminò 2-2, e fu bella davvero. Così, prima di tornare a Buenos Aires, sia il presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, che Sua Santità, il papa Pio XII, vollero incontrare i calciatori del River Plate applaudendo il loro comportamento tanto nobile, che rinsaldava il vincolo fra i popoli fratelli dell’Italia e dell’Argentina.

E questa magnifica pagina di sport e amicizia troverà una degna replica quando – in occasione dei festeggiamenti per il cinquantenario della sua fondazione – il River Plate inviterà a Buenos Aires proprio il Torino Simbolo a giocare al Monumental; così il 29 giugno 1951, davanti a quasi centomila spettatori, niente meno che il generale Perón scese sul terreno di gioco per salutare uno a uno quei calciatori giunti dall’Italia, passando in rassegna le squadre e dando il calcio d’inizio. La partita la vinceranno nettamente gli argentini per 3-1, ma il Torino sarà applaudito con entusiasmo e salutato da un magnifico striscione granata apparso sulle gradinate e dedicato al capitano del Grande Torino: “Mazzola presente”. A fine partita il presidente Novo, distrutto dal lutto sempre vivo per i suoi ragazzi scomparsi e scosso dalla commozione, aveva omaggiato gli argentini regalando loro le maglie granata, che i giocatori del River Plate indosseranno nelle stagioni successive, preferibilmente nel mese di maggio, onorando così eternamente la memoria del Grande Torino. Trascorsi sette mesi da allora il River tornerà in Italia per affrontare il Torino: accadrà il 16 gennaio 1952 al Comunale, coi granata che (quell’anno arrivarono al 15° posto su 20 e non retrocessero in Serie B per soli due punti) pur non essendo all’altezza dei loro avversari riuscirono con orgoglio a difendere un memorabile pareggio, e fu comunque grande spettacolo, sempre allo scopo di raccogliere fondi, per ovviare in questo caso ad una situazione finanziaria assai difficile per Novo, il quale – commosso sino alle lacrime – consegnerà al presidente del River, don Antonio, un piatto d’argento con inciso il motto latino Cordium consensus vitam parit novellam [Il consenso dei cuori prepara il rinnovarsi della vita], come ringraziamento per l’amicizia e la sensibilità dimostrate.

Nella successiva stagione, quella 1952/53, il Torino vestirà per la prima volta una casacca ispirata alla divisa del River Plate, aggiungendo alla tradizionale seconda maglia bianca una striscia diagonale granata; peraltro, dopo aver fantasticato di riuscire a ricostruire una grande squadra in tempi brevi e non esserci riuscito, ormai deluso, sfiduciato e annichilito dal dolore, Ferruccio Novo abbandonerà la presidenza della società, sostituito da un gruppo di dirigenti passato alla storia come il Comitato di reggenza, che governerà la società per stagioni in cui la squadra per due volte otterrà un dignitoso 9° posto; in seguito arriverà, nella stagione 1955/56, un nuovo presidente: un industriale, banchiere e senatore, Teresio Guglielmone; egli tuttavia lascerà presto per motivi di precaria salute, e gli subentrerà in una condizione di precarietà un Comitato esecutivo che, nella stagione 1956/57, cercherà di mettere ordine e del quale faranno parte: Arturo Colonna, Beniamino Gay e Antonio Vespucio Liberti. Sì, proprio “quel” don Antonio Vespucio Liberti, che addirittura dovrà assumere la direzione tecnica del Toro, accompagnando per 4 giornate di campionato sulla panchina granata – dopo l’esonero di Fioravante Baldi – il fidato Oberdan Usello, che cederà poi la guida tecnica della società a un personaggio pittoresco ma inaspettatamente efficace: un allenatore serbo, Blagoje Marjanovic, che arriverà quasi per caso e salverà il Toro che, da ultimo in classifica su 18 squadre, condurrà a fine campionato al 7° posto, realizzando una vera e propria impresa, sempre fedele al suo proclama: “Per salvarsi le tattiche difensive non servono. Bisogna avere coraggio, rischiare. Per andare avanti occorrono gol e vittorie. E convinzione!”

Questa storia di #EternaAmicizia o, se preferite, #EternaAmistad, certifica la correttezza di un’affermazione impegnativa: oltre all’amore dei suoi tifosi il Toro aveva guadagnato il rispetto di tutti gli avversari e l’ammirazione di ogni sportivo, ovunque; nessuna squadra al mondo infatti ha mai rappresentato per il calcio quello che ha significato, e significa – perché, come scrisse Indro Montanelli, gli eroi sono sempre immortali – il Grande Torino.

[Disclaimer. Le immagini digitali e/o fotografiche utilizzate sono estratte in rete e principalmente (ma non solo) dalle pagine https://it.m.wikipedia.org/ dove si legge la dichiarazione che le fotografie sono nel pubblico dominio poiché il loro copyright è scaduto o altrimenti possano essere riprodotte in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, e comunque della normativa vigente, in ragione delle mere finalità illustrative e per fini non commerciali, non costituendo concorrenza all’ipotetica utilizzazione economica dell’opera di chiunque altro].